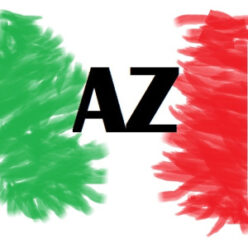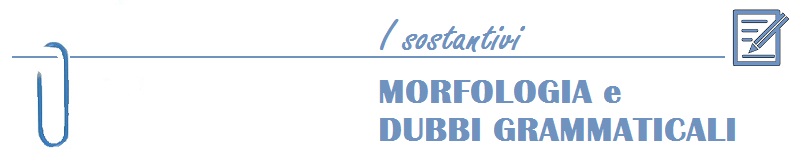
■ Perché i nomi sono maschili o femminili? ■ Come si distingue il maschile e femminile dei nomi? Si può dire che i nomi maschili terminano in O e quelli femminili in A? ■ Quali sono i nomi maschili che finiscono con la A? ■ Quali sono i nomi femminili che finiscono con la O? ■ Che differenza c’è tra “il tavolo” e “la tavola”?
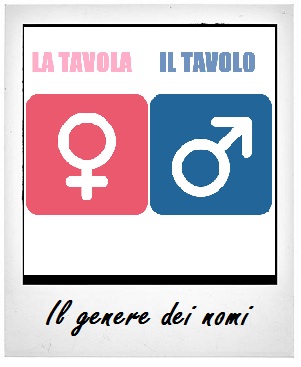
Sembra naturale e logico che un nome come mamma sia femminile e papà sia maschile, ma in realtà dal punto di vista grammaticale non esiste alcuna corrispondenza necessaria tra il genere di una parola e il sesso di ciò che designa. Quando diciamo che il canguro ha il marsupio in realtà ci riferiamo alla femmina del canguro, perché il maschio non lo possiede affatto. E così non c’è una ragione logica per cui alcuni animali siano al femminile (la tigre, la marmotta) e altri al maschile (il leone, il cammello). Questi nomi sono anche detti promiscui (comprendono entrambi i generi). Allo stesso modo, una sentinella o una guardia (femminili) non corrispondono al sesso di chi svolge queste funzioni che possono essere sia uomini sia donne.
Lettura
Ricordo, da bambino, il tavolo della cucina su cui a volte giocavo o facevo i compiti sino all’ora di cena, quando finalmente richiudevo ogni cosa. All’improvviso, quello stesso tavolo veniva ricoperto da una tovaglia bianca, come una gonna che ne copriva le gambe, e apparecchiato. Al richiamo di: “È pronto! A tavola!” tutta la famiglia si sedeva e il tavolo era diventato la tavola, al femminile, che ci nutriva. Almeno fino a quando non la si sparecchiava nuovamente e la magia era finita: ritornava a essere un tavolo, da lavoro, maschio e spoglio. Mi è sempre sembrata una bella immagine per descrivere l’essenza della nostra lingua: instabile, irrazionale, senza una logica apparente.
(Tratto da: L’italiano for dummies, Hoepli, Milano, pp.141-142).
In altri casi le parole si differenziano tra il maschile e il femminile, per esempio madre e padre, abate e badessa, e la femmina del camoscio è la camozza.

In latino esistevano tre generi, il maschile, il femminile e il neutro impiegato proprio le cose e i concetti senza sesso, ma nel passaggio all’italiano il neutro è caduto in disuso e la conseguenza è che le parole si sono mascolinizzate e femminilizzate a orecchio e senza una ragione logica. E così il mare è maschile, in italiano, mentre in francese è femminile (la mère), in spagnolo (mar) può essere maschile o femminile a seconda dei contesti (“tengo un mar de compromisos”, cioè “ho un mare di cose da fare”, oppure “la mar de gente”, un “mare di gente”). In tedesco Meer è neutro, e in inglese (sea) non c’è il problema del genere, che vive solo nei pronomi personali.
Come distinguere il maschile e il femminile dei nomi

Per chi parla e scrive, è necessario sapere quando un sostantivo è maschile o femminile per poterlo concordare correttamente con gli aggettivi e le altre parole: il pane è buono (maschile) e la torta è buona (femminile).

Bisogna fare attenzione: anche se spesso è così, non è vero che i sostantivi maschili terminano in –o e quelli femminile in –a, questa circostanza non è una regola, e pensare che sia così è un’idea ingannevole ed errata: nomi come Mattia, Battista o Andrea (per quest’ultimo vale per l’italiano, in altri Paesi può essere femminile), sono maschili, come l’automa, il poeta, il sosia, il papa e il papà, il gorilla, il cinema, il prisma, il sisma, il plasma, il carisma, il boia, il vaglia, il pigiama, il nonnulla, il pirata, il problema, lo scisma, lo stemma, lo stratagemma, l’aforisma e l’aldilà. E anche: l’asma e l’edema (“lo asma” e “lo edema”)! Viceversa, sono femminili molte parole che terminano in -o come la moto, la pallavolo, la radio, la mano, l’auto, la dinamo e anche l’eco (“la eco”), che però al plurale è sempre gli echi, al maschile.

Dopo tutti questi esempi forse è più chiaro come fare a distinguere il genere di una parola: un nome è maschile (o femminile) quando il suo articolo è maschile (e viceversa): il capitale è una somma di denaro e la capitale è la città principale di un Paese.

Come si fa a sapere quale articolo abbinare?
Non c’è una regola, c’è solo l’uso e in caso di dubbi non resta che consultare il dizionario.
A volte però le cose sono ancora più complicate e spinose, per esempio nel caso di alcuni → nomi propri geografici (che non si trovano sul dizionario).
Sul genere dei nomi vedi anche
→ “Il genere dei nomi stranieri“
→ “Il sessismo della lingua e la femminilizzazione delle cariche“
→ “Falsi cambiamenti di genere“